Industrialmente l'alcol etilico è anche prodotto per idratazione dell'etilene. L'alcol etilico è presente nelle bevande alcoliche preparate mediante fermentazione di una notevole varietà di vegetali. In particolare, il tipo di bevanda ottenuto dipende dalla sostanza usata per la fermentazione (segale o frumento, uva o bacche, ecc.), dalle condizioni di fermentazione (ad es. se l'anidride carbonica è trattenuta o meno nella miscela fermentata) e dalle operazioni che seguono la fermentazione (se il liquido viene distillato). Così, il particolare aroma della bevanda non è dovuto all'alcol etilico, bensì ad altre sostanze caratteristiche della materia prima o appositamente aggiunte.
In medicina l'alcol etilico è classificato tra gli ipnotici ed è meno tossico degli altri alcoli.
| densità | % (v/V) | % (p/P) |
| 1.000 | 0 | 0 |
| 0.887 | 70.01 | 62.46 |
| 0.874 | 75.09 | 67.98 |
| 0.846 | 85.10 | 79.57 |
| 0.809 | 95.93 | 93.82 |
| 0.806 | 96.65 | 94.88 |
| 0.790 | 100.00 | ----- |
Quasi tutto l'alcol etilico utilizzato, detto alcol a 96o è una miscela azeotropica (miscela i cui componenti bollono insieme) formata da acqua e alcol; questo perché l'alcol assoluto o alcol puro è molto più costoso in quanto si deve distillare ricorrendo ad un azeotropo ternario (acqua-alcol-benzene). In particolare, dalla tabella a destra risulta che 100 ml di alcol a 96o pesano 80,9 g ed espressi come percentuale volumetrica %(v/V) sono costituiti da 95,93 ml di alcol assoluto in 100 ml di soluzione alcolica (contenente 4.03 ml di acqua) oppure, se espressi come percentuale ponderale, %(p/P), da 93,82 g di alcol assoluto in 100 g di soluzione alcolica (contenente 6,18 g di acqua).
Per calcolare la quantità di acqua da aggiungere all'alcol a 96o allo scopo di ottenere alcol di una data gradazione inferiore, si deve tener conto che la miscelazione alcol-acqua avviene con contrazione di volume.
Per comprendere il procedimento di calcolo, ricordiamo dapprima come viene calcolata la quantità di acqua da aggiungere ad una soluzione di data concentrazione per ottenerne una più diluita. Supponiamo, ad es., di dover diluire una soluzione di NaCl con titolo 2g/ml per ottenere 10 ml di una soluzione con titolo 0.09 g/ml.
Indicando con C le concentraioni (g/ml), possiamo scrivere:
| titolo 2g/ml | C1 = | g1/ml1 |
| titolo 0.09 mg/ml | C2 = | g2/ml2 |
tenendo conto che i grammi, g1, di NaCl contenuti in ml1 della prima soluzione verranno prelevati per entrare completamente a far parte della seconda che verrà diluita per ottenere il volume necessario, risulta g1 = g2 e quindi:
| (1) C1 · ml1 = C2· ml2 |
in particolare, sostituendo i valori, si ottiene: 2 · ml1 = 0.09 · 10, da cui si ricavano i ml di soluzione 2g/ml da prelevare (ml1 = 0.45) e da diluire con acqua (9.55 ml) per ottenere 10 ml di una soluzione 0.09 g/ml.

Nel caso della diluizione dell'alcol, il calcolo deve essere sviluppato utilizzando solo le grandezze ponderali %(p/P) riportate in tabella in quanto l'operazione di diluizione comporta, come detto, una contrazione di volume.
per la diluizione dell'alcol, si applica la formula (2) che è analoga alla (1) ma espressa in unità ponderali anziché volumetriche:
| (2) P(96) · g(96) = P(70)· g(70) |
dove:
P(96) = percentuale ponderale %(p/P) di alcol a 96o;
g(96) = grammi di alcol a 96o da prelevare per la diluizione;
P(70) = percentuale ponderale %(p/P) di alcol a 70o;
g(70) = d(70) · ml (densità · ml da ottenere)
supponendo di voler ottenere 50 ml di alcol a 70o, inserendo i valori nella (2) si ottiene:
93,82 · g(96) = 62.46 · 0.887 · 50 ![]() g(96) = 29,52 g di alcol a 96o da addizionare a 0.887 · 50 - 29,52 = 14.83 g di acqua.
g(96) = 29,52 g di alcol a 96o da addizionare a 0.887 · 50 - 29,52 = 14.83 g di acqua.
|
densimetri: fondati sul principio di Archimede, sono costituiti da galleggianti di vetro opportunamente zavorrati con piombo, provvisti di un'asta graduata sulla quale si legge la densità, e spesso di un termometro che indica la temperatura.
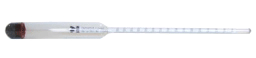
Versato il liquido dentro un cilindro di vetro, si immerge il densimetro e si legge la densità sulla graduazione dell'asta corrispondente al pelo del liquido. I densimetri danno direttamente la densità relativa all'acqua a 4 oC e sono tarati per una determinata temperatura indicata sul termometro stesso: se la lettura è effettuata a temperature differenti, occorre apportare le dovute correzioni ricavabili da apposite tabelle. |
In genere le preparazioni alcoliche della F.U. sono tinture o estratti alcolici in volumi piuttosto ridotti. Per determinare il grado alcolico, la F.U. prevede due metodi, entrambi basati sulla distillazione, che richiedono un picnometro (per la determinazione del peso specifico) o un aerometro per misurare la densità del distillato e quindi risalire alla percentuale di acqua contenuta. Per una corretta determinazione del grado alcolico, occorre eliminare tutti i componenti volatili e le sostanze disciolte nella soluzione, in quanto potrebbero alterarne la densità. Per la distillazione si prelevano 25 ml della soluzione da esaminare e si diluiscono in modo da raccogliere, dopo la distillazione, più di 100 ml. Occorre prestare attenzione alla temperatura del distillato in quanto la densità varia con essa (se la temperatura è > di 20 ºC, occorre sotrarre dal titolo alcolico un valore ricavabile dalla apposita tabella riportata sulla F.U.; il valore è sottratto se la temperatura è > 20 ºC).
Per quanto riguarda le incompatibilità dell'alcol come veicolo, occorre ricordare che precipita le proteine, con la gomma artabica e adragante si verifica insolubilizzazione, infine con il cloralio idrato forma l'acetale corrispondenmte che è insolubile ed immiscibile in acqua.
Le preparazioni galeniche in veicolo acquoso o alcolico prendono i nomi di idroliti, idrolati, alcoliti o alcolati. Accenniamo subito agli idroliti e alcoliti, trattando gli altri nella parte dedicata alle preparazioni estrattive.
idroliti: sono preparazioni in cui il veicolo acquoso viene addizionato con il farmaco. Possiamo ricordare il protargolo e la limonata citro-magnesiaca.
Il protargolo si prepara utilizzando un cilindro contenente acqua depurata, nel quale si fa cadere la polvere di argento proteinato in modo che si depositi sulla superficie, si bagni e quindi cada sul fondo ove si scioglierà (mettendo tutta la polvere direttamente in acqua si forma una massa che si scioglie difficilmente).
La limonata citro-magnesiaca si prepara con 12 parti di carbonato di Mg, 40 parti di sciroppo al limone, 20 parti di ac. citrico (E330) diluendo a 200 ml con acqua; poiché il citrato di mg che si forma è poco solubile e precipita come citrato di magnesio idrato insolubile, la preparazione deve essere fatta al momento dell'uso.
alcoliti: si preparano diluendo con alcol gli oli essenziali (v. preparazioni estrattive).
|
Le preparazioni galeniche in veicolo oleoso, prendono il nome di oleoliti: si possono preparare sciogliendo a freddo il principio attivo nell'olio, oppure facendolo digerire con l'olio a caldo. Gli oleoliti hanno una certa azione regolatrice sullo scambio idrico fra pelle ed ambiente: a causa della loro idrorepellenza, formano sull'epidermide una pellicola dadatta ad impedire l'evaporazione e, per conseguenza, aumentano l'idratazione dello strato cutaneo sottostante.
Gli oli vegetali presentano tutti la tendenza all'ossidazione e, in generale, devono essere addizionati con antiossidanti. Ancóra, gli olii si differenziano per la composizione e per diversi parametri caratteristici: indice di acidità, di iodio, di saponificazione, ecc.).
paraffine (E243): sono miscele di idrocarbri saturi che, a seconda della loro struttura a catena lineare o ramificata, presentano diversa consistenza e viscosità. In Farmacia sono molto usate la paraffina semisolida (vaselina filante) e la paraffina liquida (olio di vaselina), quast'ultima come lassativo. In generale sono sostanze idrorepellenti che non vengono assorbite dall'organismo.
olio di noce di cocco: usato largamente per la preparazione di saponi e olii solari; entrambi, comunque, irrancisiscono facilmente.
olio di mandorle dolci: estratto per spremitura meccanica dalle mandorle dolci che ne contengono fino al 50%, si presenta come un liquido giallino, limpido, inodore. La sua dermocompatibilità lo rende abbastanza usato per la preparazione di creme e unguenti; tuttavia irrancidisce facilmente producendo un odore acre e disgustoso. E' un efficace e comune rimedio contro la stitichrzza di parecchi bambini ancóra lattanti.
| 2 | ||||||||
Marcello Guidotti, copyright 2003-2007
questa pagina può essere riprodotta su qualsiasi supporto o rivista purché sia citata la fonte e l'indirizzo di questo sito (ai sensi degli artt. 2575 e 2576 cc. Legislazione sul diritto d'autore). Le fotografie sono tratte da siti web e sono, o possono ritenersi, di pubblico dominio purché utilizzate senza fini di lucro. Le immagini di prodotti presenti nel sito hanno unicamente valenza esemplificativa oltre che, eventualmente, illustrare messaggi fuorvianti e non vi è alcun richiamo diretto o indiretto alla loro qualità e/o efficacia il cui controllo è affidato alle autorità regolamentatorie.